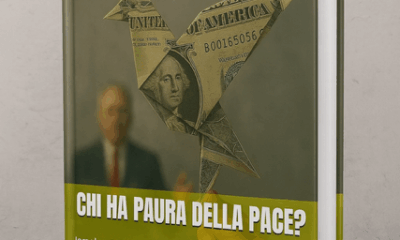Articoli
Un hombre bueno llamado Antonio

L’Osservatore Romano (6 de Octubre de 2015)
Era como si el destino quisiese cumplir su deseo. «El bien se hace y se olvida» decía. La enfermedad, en sus últimos años de vida, le hizo olvidar todo. Las personas que, como yo, lo conocieron y a quienes cambió por completo su vida, sin embargo, lo recuerdan; para siempre.
Yo tenía que enseñarle el idioma del país donde fue arzobispo; él me enseñó a amar a los demás sin esperar nada a cambio. «Vuestra religión es muy difícil para mí», le dije en tono de broma. «Si alguien me da una bofetada, no puedo ofrecerle la otra mejilla. ¡Por lo menos, le doy dos bofetadas!» respondía.
Él sonreía, consciente de que el camino de Cristo es difícil. Pocos pueden entender el significado de una fe que pone al ser humano en el centro del universo. Pocos, incluyendo a los cristianos, especialmente los cristianos, se dan cuenta de lo difícil y agotador que es seguir el camino de Jesús, por mucho que puede parecer muy claro y sencillo. Mi amigo franciscano lo intentaba y lo hacía, con gestos no con palabras.
Un día me pidió que lo acompañase en el coche, un viejo Simca, si no recuerdo mal. Estaba lleno de cosas, ropa, comida, cereales para bebés. Sentado en el asiento de al lado, noté que iba vestido «de civil»: ninguna cruz ni anillo. Nada de alzacuello blanco. Nada que pudiese revelar quién fuese. Condujo por las calles de Tánger y me di cuenta de inmediato que se dirigía hacia Dchar Bendhibane, un suburbio de mala reputación, donde yo nunca antes había estado. La pobreza por todas partes, senderos fangosos y caminos difíciles de cruzar. El padre Antonio —así lo llamaba— continuó con dificultad su camino hasta llegar a una callejuela «olvidada de la mano de Dios», uno de los peores barrios pobres.
Era evidente: no era la primera vez que él venía aquí. Una señora de ochenta años salió de la casa, seguida por toda la familia. Poco después, una sucesión de puertas que se abrían y mucha gente comenzó a acercarse a él. Lo abrazaron, lo saludaron. Yo me separé mirando la escena, estupefacto. Me pregunté cómo se las había arreglado para crear amistades en una área tan peligrosa que ni la policía se atrevía a frecuentar. Él estaba muy tranquilo, yo mucho menos.
La anciana me abordó sonriendo y me preguntó si yo era su traductor. Comprendí por qué me había llevado. Necesitaba a alguien para explicarle todo lo que decían. El padre Antonio se defendía con el árabe hablado en Marruecos, pero no podía mantener una larga conversación.
Con una diligencia casi surrealista, para ese lugar, la gente comenzó a distribuir todo lo que había llevado Antonio, como todos lo llamaban. Había mucha pobreza pero también mucha dignidad. Estaba claro que no sabían quién era. La señora nos invitó a su «casa». Té verde y rghayef, una especie de crêpe de Marruecos, pesado y lleno de aceite, que le gustaba al arzobispo. Se hablaba de esto y lo otro y yo traducía cuando era necesario. En ningún momento se habló de religión. Éramos en ese momento sólo mujeres, hombres y niños. Seres humanos, sin otros adjetivos. Era bonito.
Espero que el padre Antonio me perdone, desde el más allá, por haber contado este episodio de su vida. No quería que nadie lo supiera. Que los acontecimientos de los últimos tiempos —los inmigrantes, los refugiados, lo muros, el racismo, el fanatismo— sirvan como atenuantes para justificar mi testimonio, «no autorizado» por una persona que ya no está entre nosotros. Hombres como el antiguo arzobispo de Tánger nos dan una lección de vida y nos enseñan cómo interpretar las palabras de Jesús.
Yo, que soy de cultura musulmana, aprendí del padre Antonio Peteiro que las religiones, si no sirven para acercarse a los seres humanos, son inútiles. Es gracias a él y a la gente como él, que aprendí a no confundir religiosidad con espiritualidad. Aprendí sobre todo, que la fe nunca puede convertirse en una ideología, si no se quiere que desaparezca su sentido más humano y más profundo.
Articoli
Chi ha paura della pace?
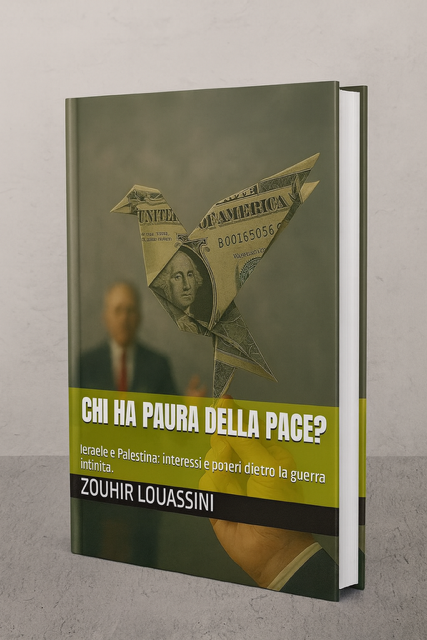
La parola pace in Medio Oriente è stata talmente usata, manipolata e svuotata che oggi sembra quasi impronunciabile. Nonostante decenni di negoziati falliti, guerre senza tregua e cicli infiniti di violenza, resta l’unica via possibile. Ma chi la ostacola? Chi ha davvero paura della pace?
È questa la domanda al centro del nuovo libro di Zouhir Louassini, giornalista e scrittore, che scava nei nodi più dolorosi del conflitto israelo-palestinese. Il volume non indulge in retorica: parte da fatti concreti, come il massacro del 7 ottobre 2023, quando Hamas ha colpito brutalmente civili innocenti, tra i quali anche israeliani impegnati nel dialogo con i palestinesi. Un atto di violenza che ha avuto un unico obiettivo: distruggere ogni possibilità di convivenza.
Ma l’autore non si ferma a denunciare la barbarie di Hamas. Con la stessa lucidità mette in luce le responsabilità del governo Netanyahu e della destra israeliana, che da anni alimentano un clima di paura, colonizzazione e vendetta. Una leadership che ha usato la retorica della sicurezza per rafforzarsi politicamente, mentre la prospettiva di una pace reale si allontanava sempre di più.
Louassini mette in parallelo queste dinamiche con l’uso distorto delle parole: leader che parlano di “pace” mentre alimentano la guerra, promesse che si trasformano in imposizioni, un linguaggio politico che ricorda le distopie di Orwell, dove i significati vengono rovesciati.
Chi ha paura della pace? è un testo giornalistico ma anche una riflessione universale: mostra come la pace faccia paura a chi vive di conflitto, a chi trae forza e consenso dall’odio. E invita i lettori a chiedersi se la guerra sia davvero inevitabile, o se esista ancora spazio per immaginare scenari pragmatici di convivenza.
Non offre illusioni, ma pone la domanda più scomoda e necessaria: la pace è davvero un’utopia, o è la nostra unica possibilità di futuro?
Articoli
Partita a scacchi su un ring di pugilato: tra Israele e Iran il nuovo round di una spirale infinita

Gaza, Hezbollah, Siria, Iran: ogni fronte è inserito in una logica coerente, volta a smantellare le reti di minaccia alla sicurezza israeliana
Nel ring infuocato del Medio Oriente, il conflitto tra Israele e Iran somiglia sempre più a un ibrido tra una partita di scacchi e un incontro di pugilato. Israele gioca con freddezza strategica: colpisce con precisione chirurgica obiettivi militari, basi e infrastrutture sensibili. Ogni mossa è calcolata, ogni attacco ha un valore operativo ma anche simbolico.
L’Iran, invece, sembra un pugile stordito. Reagisce con colpi confusi, spesso imprecisi, più guidato dall’impulso che da un piano. I droni lanciati in massa, i razzi sparati senza un bersaglio definito, le minacce ripetute ma inefficaci: tutto parla di frustrazione più che di forza.
Ma il vero squilibrio non è solo militare. È soprattutto geopolitico. Teheran si ritrova sempre più isolata. I suoi alleati storici sono in difficoltà: Hezbollah è logorato in Libano da attacchi continui e da una crisi economica devastante; gli Houthi in Yemen sono sotto tiro diretto degli Stati Uniti; Hamas, dopo l’attacco del 7 ottobre 2023, è intrappolato nella guerra brutale di Gaza. La “mezzaluna sciita”, un tempo simbolo dell’influenza regionale iraniana, si è incrinata sotto il peso della risposta israeliana e dell’isolamento diplomatico.
Anche sul piano internazionale, l’Iran non trova più appoggi solidi. La Russia, pur legata da interessi militari e strategici, è assorbita dalla guerra in Ucraina e non ha alcuna intenzione di aprire un nuovo fronte. La Cina mantiene una distanza prudente: intrattiene rapporti economici con Teheran, ma non intende compromettere la sua immagine globale per una potenza sempre più ingombrante. Mosca e Pechino giocano su più tavoli, ma oggi scelgono la cautela. Nessuno è disposto a esporsi per un Iran sempre più isolato.
Israele, al contrario, agisce con la consapevolezza di avere il vento a favore. Gli Stati Uniti garantiscono copertura diplomatica, supporto tecnologico e una forte capacità di deterrenza. Le potenze occidentali, con sfumature diverse, condividono la percezione dell’Iran come minaccia alla stabilità regionale. Anche molti paesi arabi, pur evitando dichiarazioni ufficiali, vedono con favore il contenimento dell’espansionismo iraniano. Non si può parlare di legittimità internazionale – l’ONU non ha mai approvato formalmente le azioni israeliane – ma è chiaro che Tel Aviv opera dentro un contesto di ampio consenso politico, seppur non dichiarato.
Soprattutto, Israele agisce secondo una visione. La risposta all’attacco del 7 ottobre non è stata solo militare: è parte di una strategia a lungo termine per ridisegnare gli equilibri regionali. Gaza, Hezbollah, Siria, Iran: ogni fronte è inserito in una logica coerente, volta a smantellare le reti di minaccia alla sicurezza israeliana. È una dottrina fondata su azione preventiva, superiorità tecnologica e iniziativa diplomatica.
Ma tutto questo solleva una domanda cruciale: quanto può durare questa spirale? Fino a quando la sicurezza israeliana potrà basarsi su guerre preventive, attacchi anticipati, operazioni giustificate da minacce reali o anche solo percepite? Perché anche la semplice sensazione di una minaccia, per Israele, si traduce quasi sempre in un’azione militare. È una strategia che ha prodotto risultati tattici, ma ha anche cronicizzato il conflitto. Ogni guerra genera la successiva.
Dal 1948, anno della nascita dello Stato di Israele, il Medio Oriente non ha mai conosciuto una pace duratura. Solo tregue provvisorie, pause tra una crisi e l’altra. Il paradosso è tutto qui: per difendersi, Israele è costretto ad attaccare. Ma ogni attacco riaccende il fuoco, rafforza il nemico, alimenta nuove tensioni.
Forse è il momento di affiancare alla forza una visione politica diversa. Perché la sicurezza, quella vera, nasce anche da una giustizia riconoscibile. E giustizia, in questa regione, significa accettare finalmente la creazione di uno Stato palestinese indipendente, con interlocutori legittimi e affidabili — non certo Hamas. Un processo difficile, certo, ma che potrebbe finalmente dare senso a un equilibrio fondato non solo sulla deterrenza, ma anche sulla legittimità e sul rispetto reciproco.
Finché la pace resterà un’idea astratta e non un progetto concreto, ovvero un “compromesso” ragionevole fra tutti gli Stati della regione, il Medio Oriente continuerà a giocare a scacchi con i pugni. E ogni vittoria, per quanto brillante, sarà solo il preludio a un nuovo round.
Pubblicato il 15/6/2025 su Rainews
Articoli
Tangeri, 1890. Intrigo, potere e resistenza: La strategia del pesce nano, il primo romanzo di Zouhir Louassini
Una storia avvincente ispirata a fatti reali che riporta alla luce una pagina dimenticata della storia marocchina, tra spionaggio, tensioni internazionali e dignità ferita.
 È disponibile su Amazon La strategia del pesce nano, il primo romanzo dello scrittore e giornalista marocchino Zouhir Louassini. Ambientato nella Tangeri del 1890, il libro trascina il lettore in un’indagine che va oltre il mistero iniziale – l’assassinio di un cittadino italiano – per esplorare gli intricati rapporti di forza tra il Marocco e le grandi potenze coloniali.
È disponibile su Amazon La strategia del pesce nano, il primo romanzo dello scrittore e giornalista marocchino Zouhir Louassini. Ambientato nella Tangeri del 1890, il libro trascina il lettore in un’indagine che va oltre il mistero iniziale – l’assassinio di un cittadino italiano – per esplorare gli intricati rapporti di forza tra il Marocco e le grandi potenze coloniali.
Tangeri, all’epoca, era una città di frontiera e d’intrigo, abitata da consoli stranieri, spie, mercanti e diplomatici che operavano sotto la protezione di un sistema consolare arrogante e impunito. Louassini costruisce, con eleganza narrativa e rigore storico, un giallo politico che illumina i meccanismi opachi dell’epoca, le tensioni diplomatiche e le strategie sottili adottate da chi – pur privo di potere militare – cercava di sopravvivere e difendere la propria sovranità.
Il titolo del romanzo, La strategia del pesce nano, diventa emblema di questa resistenza silenziosa: quella di chi, pur piccolo e fragile, riesce a muoversi con astuzia nel mare agitato degli imperi coloniali.
Con uno stile limpido e cinematografico, il romanzo restituisce una Tangeri affascinante e contraddittoria, sospesa tra tradizione e modernità, tra dominio straniero e orgoglio marocchino. Louassini non si limita a raccontare un fatto di cronaca: invita il lettore a riflettere sul presente, sulle relazioni di forza internazionali, e sulla sottile linea tra giustizia e impunità.