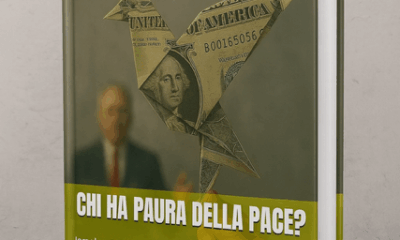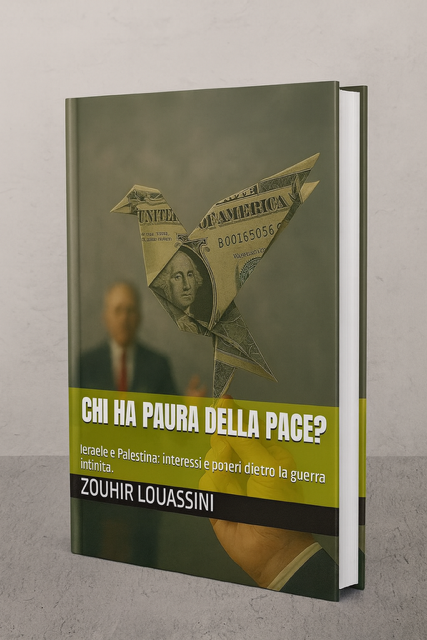Zouhir Louassini. Rainews (1-11-2025)
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato il 31 ottobre la risoluzione 2797 con undici voti a favore, tre astensioni (Russia, Cina e Pakistan) e la non partecipazione dell’Algeria. Oltre a rinnovare il mandato della missione MINURSO nel Sahara Occidentale, la risoluzione riafferma un punto politico chiave: il piano di autonomia proposto dal Marocco è considerato “la soluzione più seria, credibile e realistica” per risolvere il conflitto.
È un linguaggio che si ripete ormai da anni, ma che conferma l’orientamento prevalente all’interno del Consiglio: superare le formule ideologiche del passato e spostare il dossier sahariano su un piano pragmatico. In questa prospettiva, il piano marocchino — che prevede un’ampia autonomia sotto sovranità nazionale — si è progressivamente imposto come punto di riferimento negoziale.
Al centro della disputa non c’è solo il futuro del popolo sahrawi, ma anche e soprattutto una rivalità geopolitica di lungo corso tra Marocco e Algeria. Il conflitto sul Sahara Occidentale, infatti, ha radici più profonde e complesse rispetto a quanto spesso viene raccontato. Per anni la narrazione dominante ha insistito su un presunto diritto di autodeterminazione contrapposto a una “occupazione”, ma ha trascurato il contesto strategico in cui è nato il conflitto: un Nord Africa diviso dalla Guerra Fredda, con il Marocco tradizionalmente vicino agli interessi occidentali e l’Algeria solidamente allineata con l’Unione Sovietica e i movimenti del Terzo Mondo.
In questo quadro, la nascita del Fronte Polisario nel 1973 e la successiva proclamazione della Repubblica Araba Sahrawi Democratica nel 1976 — mai riconosciuta dalle Nazioni Unite — si inseriscono in una partita regionale più ampia. Algeri ha sostenuto il movimento sahrawi come strumento di pressione e contenimento nei confronti del Marocco. Rabat, dal canto suo, ha reagito rivendicando la propria sovranità sul territorio fin dal 1963, e consolidando la propria presenza dopo la Marcia Verde del 1975, che costrinse la Spagna a negoziare il ritiro dalla ex colonia.
Negli anni, questa contrapposizione si è congelata, cristallizzando una situazione di stallo che la diplomazia internazionale ha cercato a più riprese di sbloccare. Il Consiglio di Sicurezza ha mantenuto una linea coerente: nessuna menzione al Marocco come “potenza occupante”, nessun riconoscimento dell’indipendenza sahrawi, nessuna imposizione di un referendum. Piuttosto, un invito costante a trovare una “soluzione politica realistica e mutuamente accettabile”.
Oggi, sul terreno, il Marocco ha rafforzato la propria presenza nei territori sahariani attraverso investimenti pubblici, infrastrutture e politiche di integrazione amministrativa. Questo approccio ha attirato l’interesse di diversi Paesi africani e occidentali, anche per le implicazioni economiche e strategiche che la regione riveste: corridoi logistici verso l’Africa subsahariana, progetti energetici, sicurezza nel Sahel.
L’Algeria, invece, continua a sostenere che la questione vada risolta con un referendum che includa l’opzione dell’indipendenza, e critica il piano marocchino come una forma mascherata di annessione. Ma negli ultimi anni la sua posizione è apparsa sempre più isolata, e la scelta di non partecipare al voto del 31 ottobre riflette, probabilmente, l’intenzione di non avallare un quadro politico che considera sbilanciato.
Va detto che la soluzione non è ancora a portata di mano. Il piano marocchino ha ricevuto ampi riconoscimenti, ma non è stato formalmente accettato né dal Polisario né da Algeri. E le tensioni tra i due Paesi restano alte, con le frontiere chiuse da decenni e rapporti diplomatici interrotti.
Eppure, qualcosa si muove. La risoluzione del Consiglio di Sicurezza non risolve il conflitto, ma ridisegna le coordinate del confronto: meno spazio all’ideologia, più attenzione alla realtà. Dopo cinquant’anni di rigidità contrapposte, forse è il momento di tornare a vedere il Sahara Occidentale per quello che è: non un simbolo astratto, ma una questione politica concreta che può — e deve — trovare una soluzione.
Il dossier del Sahara Occidentale ha per decenni rappresentato una linea di frattura lungo la spina dorsale del Maghreb. Un conflitto mai esploso del tutto, ma nemmeno mai davvero sopito. Un terreno dove si sono sovrapposti nazionalismi, ideologie post-coloniali, interessi strategici e identità tribali, spesso letti con lenti polarizzate più che con strumenti di analisi politica.
Oggi, in un Nord Africa esposto a tensioni economiche, rischi di insicurezza transfrontaliera e nuove pressioni internazionali, quel dossier può — paradossalmente — diventare un punto di partenza. Un banco di prova per misurare la capacità della regione di voltare pagina.
Non si tratta di dimenticare la storia, ma di non restarne prigionieri. La sfida non è ignorare le differenze, ma costruire sui punti di convergenza: sviluppo, stabilità, dialogo, integrazione. Il Sahara Occidentale potrebbe smettere di essere una trincea ideologica per trasformarsi in un laboratorio di equilibrio.
Perché se è vero che, finora, il conflitto ha funzionato come una zavorra politica per tutto il Maghreb, è altrettanto vero che una sua soluzione — giusta, sostenibile e condivisa — potrebbe finalmente sbloccare una delle regioni più potenzialmente dinamiche del continente africano.
Il tempo delle posizioni congelate sta finendo. E con esso, forse, anche quello delle incomprensioni storiche. Sta ora alla diplomazia, e al coraggio politico delle capitali nordafricane, capire se il Sahara resterà il nodo che paralizza il Maghreb, o diventerà la chiave per rimetterlo in movimento.