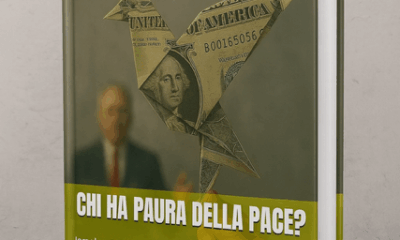Articoli
Gaza, una tregua labile tra le macerie: le cause profonde del conflitto restano senza risposta

Zouhir Louassini Rainews 16-01-2025
Se non accadrà nulla di imprevisto, una tregua è attesa per domenica prossima. Non si tratta, tuttavia, di un accordo di pace, ma di un semplice cessate il fuoco temporaneo. Ed è proprio questo il nodo cruciale: la tregua non affronta le cause profonde del conflitto né offre alcuna prospettiva concreta di una soluzione stabile e duratura. Nel frattempo, i bombardamenti continuano senza sosta, il numero delle vittime cresce inesorabilmente e Gaza appare sempre più devastata, piegata al limite delle sue possibilità.
Eppure, nonostante questa desolazione, la leadership di Hamas non rinuncia a proclamare una “vittoria”, amplificata dai movimenti islamisti e da alcune frange della sinistra araba che celebrano la resistenza contro Israele. Ma cosa rimane davvero di questa proclamata “vittoria”? Soltanto macerie, migliaia di sfollati, decine di migliaia di morti e una popolazione intrappolata in una crisi umanitaria senza fine. Dichiarare un trionfo in condizioni tanto drammatiche appare più come un esercizio di propaganda che una rappresentazione onesta della realtà.
Hamas, inoltre, sembra incapace o forse volutamente restio a riconoscere i profondi cambiamenti che hanno trasformato il panorama geopolitico della regione negli ultimi quindici mesi. Hezbollah, un tempo al centro delle dinamiche di potere, ha visto indebolirsi la propria influenza; l’Iran, a lungo protagonista, ha subito sconfitte decisive che ne hanno ridimensionato il ruolo nella regione. Nel frattempo, il regime di Bashar al-Assad è crollato, aprendo la strada a un nuovo governo impegnato a riconquistare il controllo sulla Siria. In Libano, un nuovo presidente cerca di ristabilire l’autorità dello Stato, lavorando per ricondurre le milizie di Hezbollah sotto il comando centrale, un passaggio che sta ridisegnando i fragili equilibri interni ed esterni del Paese.
Parallelamente, Hamas sembra ignorare il ruolo crescente della Turchia di Erdogan, che si sta affermando come uno dei principali vincitori di questi sconvolgimenti regionali. Con una strategia chiara e ambiziosa, Erdogan sta capitalizzando sui vuoti di potere lasciati dall’Iran, espandendo la propria influenza economica, politica e militare. Dal Mediterraneo orientale alla Libia, passando per il Medio Oriente, la Turchia si posiziona come una potenza regionale, richiamando l’eredità e l’ambizione dell’antico Impero Ottomano. Questo dinamismo turco si intreccia con la debolezza degli attori tradizionali, rendendo Ankara un interlocutore chiave nel nuovo assetto geopolitico.
Paradossalmente, le azioni di Hamas hanno fornito anche una via d’uscita politica a Benjamin Netanyahu. Prima del 7 ottobre, il primo ministro israeliano affrontava una crisi politica interna senza precedenti, aggravata dalle proteste contro le sue riforme giudiziarie e dal crescente malcontento nei suoi confronti. Tuttavia, il conflitto con Gaza gli ha permesso di ridefinire la sua immagine, trasformandolo in un difensore degli interessi nazionali. Oggi Netanyahu si presenta come una figura quasi eroica, sostenuta da un’opinione pubblica unita nel percepire il conflitto come una questione esistenziale.
Riconoscere le responsabilità di Hamas, tuttavia, non significa ignorare quelle di Israele nella situazione attuale. Il conflitto in Medio Oriente non è iniziato il 7 ottobre, ma affonda le sue radici in decenni di tensioni, errori e incomprensioni. Senza una piena consapevolezza dei fattori storici e politici che hanno condotto a questa realtà, Israele rischia di ripetere gli stessi errori. La forza militare da sola non è sufficiente: servono visione, strategia e comprensione delle dinamiche regionali. Solo così sarà possibile non solo vincere, ma costruire un futuro sostenibile. Questo approccio potrebbe rappresentare un elemento cruciale per qualunque reale prospettiva di pace.
Questi sviluppi, che avrebbero dovuto stimolare una revisione strategica da parte di Hamas, sono invece stati ignorati. Il movimento appare ancorato a una visione politica e strategica superata, incapace di adattarsi alla velocità con cui il Medio Oriente evolve. Questa cecità politica non solo isola ulteriormente Gaza, ma condanna la sua popolazione a restare prigioniera di un’ideologia distante dalla realtà e dalle necessità più urgenti, fino alla prossima guerra e alla futura tregua.
Articoli
Sahara Occidentale, l’ONU rafforza il sostegno al piano marocchino.

Zouhir Louassini. Rainews (1-11-2025)
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato il 31 ottobre la risoluzione 2797 con undici voti a favore, tre astensioni (Russia, Cina e Pakistan) e la non partecipazione dell’Algeria. Oltre a rinnovare il mandato della missione MINURSO nel Sahara Occidentale, la risoluzione riafferma un punto politico chiave: il piano di autonomia proposto dal Marocco è considerato “la soluzione più seria, credibile e realistica” per risolvere il conflitto.
È un linguaggio che si ripete ormai da anni, ma che conferma l’orientamento prevalente all’interno del Consiglio: superare le formule ideologiche del passato e spostare il dossier sahariano su un piano pragmatico. In questa prospettiva, il piano marocchino — che prevede un’ampia autonomia sotto sovranità nazionale — si è progressivamente imposto come punto di riferimento negoziale.
Al centro della disputa non c’è solo il futuro del popolo sahrawi, ma anche e soprattutto una rivalità geopolitica di lungo corso tra Marocco e Algeria. Il conflitto sul Sahara Occidentale, infatti, ha radici più profonde e complesse rispetto a quanto spesso viene raccontato. Per anni la narrazione dominante ha insistito su un presunto diritto di autodeterminazione contrapposto a una “occupazione”, ma ha trascurato il contesto strategico in cui è nato il conflitto: un Nord Africa diviso dalla Guerra Fredda, con il Marocco tradizionalmente vicino agli interessi occidentali e l’Algeria solidamente allineata con l’Unione Sovietica e i movimenti del Terzo Mondo.
In questo quadro, la nascita del Fronte Polisario nel 1973 e la successiva proclamazione della Repubblica Araba Sahrawi Democratica nel 1976 — mai riconosciuta dalle Nazioni Unite — si inseriscono in una partita regionale più ampia. Algeri ha sostenuto il movimento sahrawi come strumento di pressione e contenimento nei confronti del Marocco. Rabat, dal canto suo, ha reagito rivendicando la propria sovranità sul territorio fin dal 1963, e consolidando la propria presenza dopo la Marcia Verde del 1975, che costrinse la Spagna a negoziare il ritiro dalla ex colonia.
Negli anni, questa contrapposizione si è congelata, cristallizzando una situazione di stallo che la diplomazia internazionale ha cercato a più riprese di sbloccare. Il Consiglio di Sicurezza ha mantenuto una linea coerente: nessuna menzione al Marocco come “potenza occupante”, nessun riconoscimento dell’indipendenza sahrawi, nessuna imposizione di un referendum. Piuttosto, un invito costante a trovare una “soluzione politica realistica e mutuamente accettabile”.
Oggi, sul terreno, il Marocco ha rafforzato la propria presenza nei territori sahariani attraverso investimenti pubblici, infrastrutture e politiche di integrazione amministrativa. Questo approccio ha attirato l’interesse di diversi Paesi africani e occidentali, anche per le implicazioni economiche e strategiche che la regione riveste: corridoi logistici verso l’Africa subsahariana, progetti energetici, sicurezza nel Sahel.
L’Algeria, invece, continua a sostenere che la questione vada risolta con un referendum che includa l’opzione dell’indipendenza, e critica il piano marocchino come una forma mascherata di annessione. Ma negli ultimi anni la sua posizione è apparsa sempre più isolata, e la scelta di non partecipare al voto del 31 ottobre riflette, probabilmente, l’intenzione di non avallare un quadro politico che considera sbilanciato.
Va detto che la soluzione non è ancora a portata di mano. Il piano marocchino ha ricevuto ampi riconoscimenti, ma non è stato formalmente accettato né dal Polisario né da Algeri. E le tensioni tra i due Paesi restano alte, con le frontiere chiuse da decenni e rapporti diplomatici interrotti.
Eppure, qualcosa si muove. La risoluzione del Consiglio di Sicurezza non risolve il conflitto, ma ridisegna le coordinate del confronto: meno spazio all’ideologia, più attenzione alla realtà. Dopo cinquant’anni di rigidità contrapposte, forse è il momento di tornare a vedere il Sahara Occidentale per quello che è: non un simbolo astratto, ma una questione politica concreta che può — e deve — trovare una soluzione.
Il dossier del Sahara Occidentale ha per decenni rappresentato una linea di frattura lungo la spina dorsale del Maghreb. Un conflitto mai esploso del tutto, ma nemmeno mai davvero sopito. Un terreno dove si sono sovrapposti nazionalismi, ideologie post-coloniali, interessi strategici e identità tribali, spesso letti con lenti polarizzate più che con strumenti di analisi politica.
Oggi, in un Nord Africa esposto a tensioni economiche, rischi di insicurezza transfrontaliera e nuove pressioni internazionali, quel dossier può — paradossalmente — diventare un punto di partenza. Un banco di prova per misurare la capacità della regione di voltare pagina.
Non si tratta di dimenticare la storia, ma di non restarne prigionieri. La sfida non è ignorare le differenze, ma costruire sui punti di convergenza: sviluppo, stabilità, dialogo, integrazione. Il Sahara Occidentale potrebbe smettere di essere una trincea ideologica per trasformarsi in un laboratorio di equilibrio.
Perché se è vero che, finora, il conflitto ha funzionato come una zavorra politica per tutto il Maghreb, è altrettanto vero che una sua soluzione — giusta, sostenibile e condivisa — potrebbe finalmente sbloccare una delle regioni più potenzialmente dinamiche del continente africano.
Il tempo delle posizioni congelate sta finendo. E con esso, forse, anche quello delle incomprensioni storiche. Sta ora alla diplomazia, e al coraggio politico delle capitali nordafricane, capire se il Sahara resterà il nodo che paralizza il Maghreb, o diventerà la chiave per rimetterlo in movimento.
Articoli
Chi ha paura della pace?
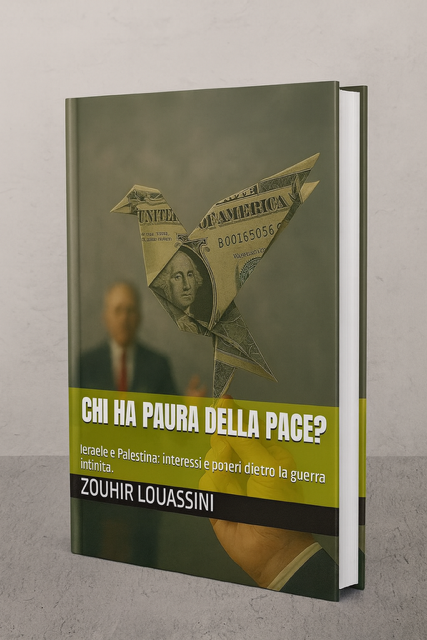
La parola pace in Medio Oriente è stata talmente usata, manipolata e svuotata che oggi sembra quasi impronunciabile. Nonostante decenni di negoziati falliti, guerre senza tregua e cicli infiniti di violenza, resta l’unica via possibile. Ma chi la ostacola? Chi ha davvero paura della pace?
È questa la domanda al centro del nuovo libro di Zouhir Louassini, giornalista e scrittore, che scava nei nodi più dolorosi del conflitto israelo-palestinese. Il volume non indulge in retorica: parte da fatti concreti, come il massacro del 7 ottobre 2023, quando Hamas ha colpito brutalmente civili innocenti, tra i quali anche israeliani impegnati nel dialogo con i palestinesi. Un atto di violenza che ha avuto un unico obiettivo: distruggere ogni possibilità di convivenza.
Ma l’autore non si ferma a denunciare la barbarie di Hamas. Con la stessa lucidità mette in luce le responsabilità del governo Netanyahu e della destra israeliana, che da anni alimentano un clima di paura, colonizzazione e vendetta. Una leadership che ha usato la retorica della sicurezza per rafforzarsi politicamente, mentre la prospettiva di una pace reale si allontanava sempre di più.
Louassini mette in parallelo queste dinamiche con l’uso distorto delle parole: leader che parlano di “pace” mentre alimentano la guerra, promesse che si trasformano in imposizioni, un linguaggio politico che ricorda le distopie di Orwell, dove i significati vengono rovesciati.
Chi ha paura della pace? è un testo giornalistico ma anche una riflessione universale: mostra come la pace faccia paura a chi vive di conflitto, a chi trae forza e consenso dall’odio. E invita i lettori a chiedersi se la guerra sia davvero inevitabile, o se esista ancora spazio per immaginare scenari pragmatici di convivenza.
Non offre illusioni, ma pone la domanda più scomoda e necessaria: la pace è davvero un’utopia, o è la nostra unica possibilità di futuro?
Articoli
Partita a scacchi su un ring di pugilato: tra Israele e Iran il nuovo round di una spirale infinita

Gaza, Hezbollah, Siria, Iran: ogni fronte è inserito in una logica coerente, volta a smantellare le reti di minaccia alla sicurezza israeliana
Nel ring infuocato del Medio Oriente, il conflitto tra Israele e Iran somiglia sempre più a un ibrido tra una partita di scacchi e un incontro di pugilato. Israele gioca con freddezza strategica: colpisce con precisione chirurgica obiettivi militari, basi e infrastrutture sensibili. Ogni mossa è calcolata, ogni attacco ha un valore operativo ma anche simbolico.
L’Iran, invece, sembra un pugile stordito. Reagisce con colpi confusi, spesso imprecisi, più guidato dall’impulso che da un piano. I droni lanciati in massa, i razzi sparati senza un bersaglio definito, le minacce ripetute ma inefficaci: tutto parla di frustrazione più che di forza.
Ma il vero squilibrio non è solo militare. È soprattutto geopolitico. Teheran si ritrova sempre più isolata. I suoi alleati storici sono in difficoltà: Hezbollah è logorato in Libano da attacchi continui e da una crisi economica devastante; gli Houthi in Yemen sono sotto tiro diretto degli Stati Uniti; Hamas, dopo l’attacco del 7 ottobre 2023, è intrappolato nella guerra brutale di Gaza. La “mezzaluna sciita”, un tempo simbolo dell’influenza regionale iraniana, si è incrinata sotto il peso della risposta israeliana e dell’isolamento diplomatico.
Anche sul piano internazionale, l’Iran non trova più appoggi solidi. La Russia, pur legata da interessi militari e strategici, è assorbita dalla guerra in Ucraina e non ha alcuna intenzione di aprire un nuovo fronte. La Cina mantiene una distanza prudente: intrattiene rapporti economici con Teheran, ma non intende compromettere la sua immagine globale per una potenza sempre più ingombrante. Mosca e Pechino giocano su più tavoli, ma oggi scelgono la cautela. Nessuno è disposto a esporsi per un Iran sempre più isolato.
Israele, al contrario, agisce con la consapevolezza di avere il vento a favore. Gli Stati Uniti garantiscono copertura diplomatica, supporto tecnologico e una forte capacità di deterrenza. Le potenze occidentali, con sfumature diverse, condividono la percezione dell’Iran come minaccia alla stabilità regionale. Anche molti paesi arabi, pur evitando dichiarazioni ufficiali, vedono con favore il contenimento dell’espansionismo iraniano. Non si può parlare di legittimità internazionale – l’ONU non ha mai approvato formalmente le azioni israeliane – ma è chiaro che Tel Aviv opera dentro un contesto di ampio consenso politico, seppur non dichiarato.
Soprattutto, Israele agisce secondo una visione. La risposta all’attacco del 7 ottobre non è stata solo militare: è parte di una strategia a lungo termine per ridisegnare gli equilibri regionali. Gaza, Hezbollah, Siria, Iran: ogni fronte è inserito in una logica coerente, volta a smantellare le reti di minaccia alla sicurezza israeliana. È una dottrina fondata su azione preventiva, superiorità tecnologica e iniziativa diplomatica.
Ma tutto questo solleva una domanda cruciale: quanto può durare questa spirale? Fino a quando la sicurezza israeliana potrà basarsi su guerre preventive, attacchi anticipati, operazioni giustificate da minacce reali o anche solo percepite? Perché anche la semplice sensazione di una minaccia, per Israele, si traduce quasi sempre in un’azione militare. È una strategia che ha prodotto risultati tattici, ma ha anche cronicizzato il conflitto. Ogni guerra genera la successiva.
Dal 1948, anno della nascita dello Stato di Israele, il Medio Oriente non ha mai conosciuto una pace duratura. Solo tregue provvisorie, pause tra una crisi e l’altra. Il paradosso è tutto qui: per difendersi, Israele è costretto ad attaccare. Ma ogni attacco riaccende il fuoco, rafforza il nemico, alimenta nuove tensioni.
Forse è il momento di affiancare alla forza una visione politica diversa. Perché la sicurezza, quella vera, nasce anche da una giustizia riconoscibile. E giustizia, in questa regione, significa accettare finalmente la creazione di uno Stato palestinese indipendente, con interlocutori legittimi e affidabili — non certo Hamas. Un processo difficile, certo, ma che potrebbe finalmente dare senso a un equilibrio fondato non solo sulla deterrenza, ma anche sulla legittimità e sul rispetto reciproco.
Finché la pace resterà un’idea astratta e non un progetto concreto, ovvero un “compromesso” ragionevole fra tutti gli Stati della regione, il Medio Oriente continuerà a giocare a scacchi con i pugni. E ogni vittoria, per quanto brillante, sarà solo il preludio a un nuovo round.
Pubblicato il 15/6/2025 su Rainews