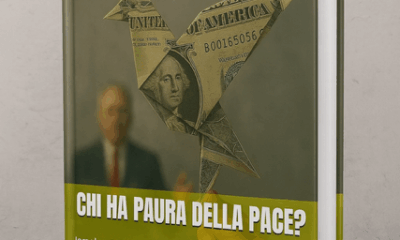Articoli
Il Mediterraneo spazio della memoria

Il 29 aprile, presso l’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, si è svolto il seminario: L’arcipelago della convergenza. Il Mediterraneo come spazio della memoria tra Islam e Europa. L’evento, organizzato dall’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha posto il problema di una necessaria rivalutazione dei rapporti tra Islam e Europa, a partire dal Mediterraneo come spazio geo-culturale di convergenza e di co-appartenenza tra due civiltà e due sponde che, oggi più che mai si percepiscono distanti. Che piaccia oppure no, il Mediterraneo è un mare che, da sempre, tiene insieme Islam e Europa: non può e non deve essere inteso come il porto sepolto o il memoriale di scambi commerciali, migrazioni culturali, financo conflitti, tra due fittizie identità come quella di Oriente e Occidente. Invero, occorre accettare il suo esser origine ma nello stesso tempo vita pulsante e forza vivificante, i cui flutti continuano a dare forma al sapere da una parte e l’altra delle sue sponde, accogliendo il molteplice nelle sue più remote appartenenze. Come dichiarato nel manifesto dell’incontro, uno degli intenti del seminario era quello di proporre al dibattito storiografico una più ampia prospettiva sul Mediterraneo, per favorire l’ampliamento delle reciproche conoscenze e un vero confronto tra le diverse componenti: europea, asiatica ed africana e al fine di sanare lo squilibrio di conoscenze e contrastare così i crescenti pregiudizi.
Nell’introdurre il Seminario Anna Maria Oliva ha sottolineato come si registri una certa difficoltà nel definire i caratteri dell’identità Europea. Alcuni l’hanno rintracciata in un nucleo post-carolingio poi esteso ad una area più ampia in un periodo che va dal X al XIV secolo, lo stesso, però, che la medievistica europea ha ormai acquisito come il lungo lasso di tempo in cui il Mediterraneo acquista la sua centralità. Vi è dunque una duplicità di prospettiva che perdura anche oggi e che spesso emerge anche nelle politiche della Comunità Europea. E’ necessario andare oltre l’attitudine storiografica ancora molto forte di considerare il Mediterraneo solo in termini di sviluppo economico e commerciale dell’Occidente ricercando una composizione tra l’area continentale e l’area mediterranea in passato così legata all’Oriente e al mondo bizantino e musulmano.
Ha quindi preso la parola Michele Scarpati che ha ricordato come le riflessioni che hanno suggerito il Seminario intrecciano percorsi che appartengono alla geografia umana ben oltre i confini geo-politici dell’arcipelago mediterraneo. Si tratta, ha proseguito Scarpati, di correggere una postura ideologica: la Reconquista e l’apertura atlantica segnano un cambiamento dei rapporti di forza tra la riva nord e quella sud del Mediterraneo. L’Europa ha organizzato la rappresentazione dello spazio mediterraneo secondo un modello che segue lo sviluppo e le logiche del suo pensiero a partire dal XVI secolo. Tuttavia l’esistenza di una straordinaria convergenza mediterranea è suffragata, tra l’altro, dalle più recenti ricerche sul lessico filosofico arabo che dimostrano la straordinaria continuità in un periodo che va dal 500 al 100 dopo Cristo tra culture apparentemente distanti e la stretta relazione tra pensiero greco, pensiero ebraico, cristiano, islamico e speculazioni in lingua armena, siriaca e in sanscrito. In questo ambito la filosofia araba ha rappresentato un fondamentale punto di snodo tra Europa e Asia, nonostante la tendenza europea a ridurre o marginalizzare l’importanza e l’originalità del pensiero arabo-islamico. Lo spunto per il seminario è venuto anche dalle riflessioni di alcuni pensatori magrebini: egiziani e algerini che si sono formati, però, in Europa; questi intellettuali arabi si sono interrogati su cosa significasse la cultura e la realtà mediterranea per le due società, europea e nord africana ed hanno evidenziato quanto, tutto sommato, fosse marginale il ruolo del Mediterraneo nella costruzione dell’odierna Unità Europea.
“L’incontro di oggi – ha sottolineato in conclusione Scarpati – vuole dunque offrire una opportunità di confronto e riflessione per sferrare un colpoo d’artiglio ontologico sulla radicalizzazione tra Occidente e Oriente ritrovando nel Mediterraneo le coordinate di un incontro da coniugare al presente”.
I lavori si sono aperti con la lettura della Prof.ssa Francesca Corrao del contributo del Prof. Massimo Campanini che non è potuto intervenire. Campanini ha introdotto il tema del mito del viaggio (tra Oriente e Occidente) attraverso un percorso tematico che ha narrato e intrecciato le storie di Dante, Ulisse, Nietzsche e il poeta musulmano-pakistano del XX secolo, Muhammad Iqbāl. Comparando il paradigma del viaggio tra la tradizione giudeo-cristiana e quella islamica, Campanini ha cercato di indagare – tra queste differenti tradizioni culturali – la natura del viaggio inteso come telos e non come puro moto a luogo.
In ambito occidentale , secondo Campanini, il viaggio che va da Ulisse a Dante e oltre non termina con un cambiamento, una trasformazione o evoluzione personale del viaggiatore. Il viaggio nell’Islam invece, è un viaggio che giunge a una meta, cioè a una distinzione tra un prima e un dopo temporali, spirituali, cioè nel senso della Rivelazione di Dio; arriva dunque a far comprendere all’uomo, il determinarsi dell’evoluzione della storia nell’ottica della presenza e del messaggio di Dio. Tra Muhammad Iqbāl e Dante, la figura di Nietzsche si pone provocatoriamente come figura mediana, poiché Nietzsche, pur non essendo un viaggiatore, si fa interprete del senso nichilistico della fine del mondo e della fine dei valori della civiltà contemporanea e anche come colui che è capace di transire. Secondo Campanini in Nietzsche si ritrova l’idea del viaggio, la cui destinazione è il superamento delle possibilità umane e dunque anche di recupero del tempo.
Sempre sul tema del viaggio, è intervenuto il Prof. Amedeo Feniello, che ha narrato il viaggio dell’arciprete Leone, vissuto alla corte del Duca Giovanni III, e inviato nel 956 da quest’ultimo a Constantinopoli. Il viaggio di Leone, ha sottolineato Feniello non è stata una semplice missione diplomatica, ma rivela importanti ragioni di commercio culturale: infatti Giovanni ordinò a Leone di cercare, selezionare e ricopiare importanti opere (letterarie, scientifiche, storiche etc…) da riportare a Napoli per ampliare e arricchire la propria personale biblioteca. I titoli delle opere richieste colpiscono, per la varietà. Tra i testi ricopiati, un ruolo di primo piano è quello de: il Romanzo d’Alessandro, la storia leggendaria delle guerre e dei viaggi di Alessandro Magno. Testo tradotto dal greco al latino che ebbe una straordinaria fortuna in tutte le corti europee. Feniello ha ricordato oltre al commercio inter-culturale anche l’esistenza di uno sviluppato ed esteso circuito commerciale in tutto il Mediterraneo, basato su rapporti fiduciari, tra società e individui, differenti per appartenenza etnica e religiosa, sottolineando ancora una volta lo straordinario sincretismo, pur in presenza di conflitti, delle società mediterranee medioevali. I musulmani ad esempio conoscevano e utilizzavano forme di contratto simile alla commenda;queste tipologie di contratto e di scambio commerciale-economico, erano condivise da tutte le civiltà attive nel Mediterraneo, pur subendo modificazioni linguistiche e di contenuto, anche in base alle esigenze e all’utilizzo di ogni specifica società.
È quindi intervenuta la Prof.ssa Francesca Corrao che ha illustrando l’influenza arabo-musulmana in Sicilia in ambito letterario, attraverso la lettura di alcuni versi di poesie di autori mussulmani che hanno particolarmente influenzato la poetica dell’epoca di Federico II di Svevia. Tema, ancora troppo poco conosciuto, e quasi del tutto assente dalle ricostruzioni della Scuola poetica siciliana. Corrao ha invece rintracciato, attraverso l’analisi di diversi brani poetici, l’influenza dei poeti arabi siciliani (basti pensare al grande Ibn Hamdis) su autori come Giacomo da Lentini (in particolar modo l’uso delle allitterazioni alla maniera araba).
Corrao ha ricordato, inoltre, che l’esercito arabo che conquistò la Sicilia, era composto non solo da musulmani, ma anche da berberi di differenti religioni – il che dimostra ancora una volta come in quel periodo fosse effettiva la convivenza tra credi religiosi diversi. L’ampio ed articolato panorama multidisciplinare offerto da Corrao ha introdotto anche le recenti scoperte archeologiche che hanno portato alla luce reperti (in un periodo cronologico che va dall’827 al 1040), che dimostrano l’introduzione araba nell’isola di colorazioni come il verde e il giallo e l’utilizzo della tecnica dell’invetriatura fino ad allora sconosciuta in Sicilia. Oltre alle ceramiche, a Palermo venne avviato anche il commercio e la produzione della seta, venne introdotta la coltivazione delle arance, dei limoni e innovativi sistemi di irrigazione.
Di mondo arabo contemporaneo, ha invece parlato Zouhir Louassini. Il giornalista della Rai, esaminando il problematico rapporto tra l’Io europeo e l’altro arabo-musulmano, ha ragionato sulle diverse forme della rappresentazione tra Islam e Europa, con una attenzione particolare a quelle veicolate dai media. Ricordando una delle principali opere dello storico marocchino Abdallah Laroui, L’idéologie arabe contemporaine: essai critique, Louassini ha circoscritto ulteriormente il problema della nascita di una ideologia araba che si esprime relazionandosi costantemente all’Occidente e ai suoi valori. Secondo Louassini, il lavoro di Laroui, è fondamentale per comprendere il quadro delle relazioni tra mondo arabo-musulmano e mondo cristiano-europeo, poiché egli teorizza tre modelli antropologici che corrispondono a tre approcci differenti tra l’Io arabo e l’altro occidentale. I primi due vedono nell’Occidente un modello tecnico e un riferimento per la costruzione di una democrazia liberale, capace di far uscire il mondo arabo dall’oscurantismo (risalente all’egemonia ottomana) e aggiornare le categorie del mondo arabo alla modernità. La terza tipologia antropologica continua a visualizzare il mondo per opposizioni, principalmente religiose, guarda all’Islam come una religione superiore al Cristianesimo e non trova nell’Occidente né un modello di confronto né una possibile fonte di dialogo. Infine Louassini ha narrato anche delle difficoltà che incontrano i musulmani e più in generale tutti gli arabi o di origine araba che vivono in Europa; infatti, sono spesso al centro di pregiudizi e accuse per fatti come gli attentati terroristici che, in realtà, non hanno niente a che vedere con l’Islam né con coloro che sono ormai radicati in Europa. In chiusura il giornalista ha ricordato come i mezzi di comunicazione, in Europa così come nei paesi arabi, siano determinanti nell’accentuare una dialettica amico/nemico, in funzione di ideologie politiche e di interessi economici che non tengono conto della reale complessità di una storia che unisce le civiltà mediterranee. Louassini ha poi fatto una rapida analisi storica di come le due società araba e europea abbiano, nel corso del dopo guerra e dopo il periodo coloniale, attraversato fasi diverse di avvicinamento e di allontanamento in conseguenza della situazione geopolitica internazionale.
Tutti gli interventi, pur se da prospettive diverse, hanno evidenziato elementi importanti di un comune patrimonio culturale in una analisi che, dall’alto medioevo sino alla contemporaneità, ha offerto un panorama ricco ed interessante dei reciproci rapporti ed influssi. Le riflessioni poi sulle stagioni a noi più vicine e sull’attualità hanno messo in luce l’urgenza di favorire e riprendere un dialogo comparato e interdisciplinare sulla storia del Mediterraneo, perché le due rive possano finalmente ritrovarsi come estremi di un ricominciamento culturale sempre possibile e non come opposti divisi, dogmaticamente e ideologicamente cinti di mura.
Articoli
Chi ha paura della pace?
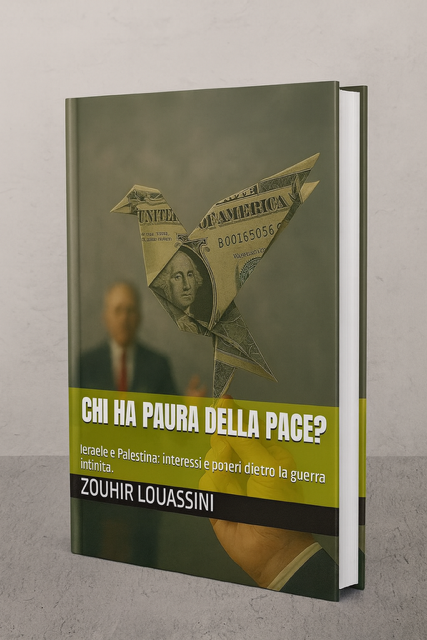
La parola pace in Medio Oriente è stata talmente usata, manipolata e svuotata che oggi sembra quasi impronunciabile. Nonostante decenni di negoziati falliti, guerre senza tregua e cicli infiniti di violenza, resta l’unica via possibile. Ma chi la ostacola? Chi ha davvero paura della pace?
È questa la domanda al centro del nuovo libro di Zouhir Louassini, giornalista e scrittore, che scava nei nodi più dolorosi del conflitto israelo-palestinese. Il volume non indulge in retorica: parte da fatti concreti, come il massacro del 7 ottobre 2023, quando Hamas ha colpito brutalmente civili innocenti, tra i quali anche israeliani impegnati nel dialogo con i palestinesi. Un atto di violenza che ha avuto un unico obiettivo: distruggere ogni possibilità di convivenza.
Ma l’autore non si ferma a denunciare la barbarie di Hamas. Con la stessa lucidità mette in luce le responsabilità del governo Netanyahu e della destra israeliana, che da anni alimentano un clima di paura, colonizzazione e vendetta. Una leadership che ha usato la retorica della sicurezza per rafforzarsi politicamente, mentre la prospettiva di una pace reale si allontanava sempre di più.
Louassini mette in parallelo queste dinamiche con l’uso distorto delle parole: leader che parlano di “pace” mentre alimentano la guerra, promesse che si trasformano in imposizioni, un linguaggio politico che ricorda le distopie di Orwell, dove i significati vengono rovesciati.
Chi ha paura della pace? è un testo giornalistico ma anche una riflessione universale: mostra come la pace faccia paura a chi vive di conflitto, a chi trae forza e consenso dall’odio. E invita i lettori a chiedersi se la guerra sia davvero inevitabile, o se esista ancora spazio per immaginare scenari pragmatici di convivenza.
Non offre illusioni, ma pone la domanda più scomoda e necessaria: la pace è davvero un’utopia, o è la nostra unica possibilità di futuro?
Articoli
Partita a scacchi su un ring di pugilato: tra Israele e Iran il nuovo round di una spirale infinita

Gaza, Hezbollah, Siria, Iran: ogni fronte è inserito in una logica coerente, volta a smantellare le reti di minaccia alla sicurezza israeliana
Nel ring infuocato del Medio Oriente, il conflitto tra Israele e Iran somiglia sempre più a un ibrido tra una partita di scacchi e un incontro di pugilato. Israele gioca con freddezza strategica: colpisce con precisione chirurgica obiettivi militari, basi e infrastrutture sensibili. Ogni mossa è calcolata, ogni attacco ha un valore operativo ma anche simbolico.
L’Iran, invece, sembra un pugile stordito. Reagisce con colpi confusi, spesso imprecisi, più guidato dall’impulso che da un piano. I droni lanciati in massa, i razzi sparati senza un bersaglio definito, le minacce ripetute ma inefficaci: tutto parla di frustrazione più che di forza.
Ma il vero squilibrio non è solo militare. È soprattutto geopolitico. Teheran si ritrova sempre più isolata. I suoi alleati storici sono in difficoltà: Hezbollah è logorato in Libano da attacchi continui e da una crisi economica devastante; gli Houthi in Yemen sono sotto tiro diretto degli Stati Uniti; Hamas, dopo l’attacco del 7 ottobre 2023, è intrappolato nella guerra brutale di Gaza. La “mezzaluna sciita”, un tempo simbolo dell’influenza regionale iraniana, si è incrinata sotto il peso della risposta israeliana e dell’isolamento diplomatico.
Anche sul piano internazionale, l’Iran non trova più appoggi solidi. La Russia, pur legata da interessi militari e strategici, è assorbita dalla guerra in Ucraina e non ha alcuna intenzione di aprire un nuovo fronte. La Cina mantiene una distanza prudente: intrattiene rapporti economici con Teheran, ma non intende compromettere la sua immagine globale per una potenza sempre più ingombrante. Mosca e Pechino giocano su più tavoli, ma oggi scelgono la cautela. Nessuno è disposto a esporsi per un Iran sempre più isolato.
Israele, al contrario, agisce con la consapevolezza di avere il vento a favore. Gli Stati Uniti garantiscono copertura diplomatica, supporto tecnologico e una forte capacità di deterrenza. Le potenze occidentali, con sfumature diverse, condividono la percezione dell’Iran come minaccia alla stabilità regionale. Anche molti paesi arabi, pur evitando dichiarazioni ufficiali, vedono con favore il contenimento dell’espansionismo iraniano. Non si può parlare di legittimità internazionale – l’ONU non ha mai approvato formalmente le azioni israeliane – ma è chiaro che Tel Aviv opera dentro un contesto di ampio consenso politico, seppur non dichiarato.
Soprattutto, Israele agisce secondo una visione. La risposta all’attacco del 7 ottobre non è stata solo militare: è parte di una strategia a lungo termine per ridisegnare gli equilibri regionali. Gaza, Hezbollah, Siria, Iran: ogni fronte è inserito in una logica coerente, volta a smantellare le reti di minaccia alla sicurezza israeliana. È una dottrina fondata su azione preventiva, superiorità tecnologica e iniziativa diplomatica.
Ma tutto questo solleva una domanda cruciale: quanto può durare questa spirale? Fino a quando la sicurezza israeliana potrà basarsi su guerre preventive, attacchi anticipati, operazioni giustificate da minacce reali o anche solo percepite? Perché anche la semplice sensazione di una minaccia, per Israele, si traduce quasi sempre in un’azione militare. È una strategia che ha prodotto risultati tattici, ma ha anche cronicizzato il conflitto. Ogni guerra genera la successiva.
Dal 1948, anno della nascita dello Stato di Israele, il Medio Oriente non ha mai conosciuto una pace duratura. Solo tregue provvisorie, pause tra una crisi e l’altra. Il paradosso è tutto qui: per difendersi, Israele è costretto ad attaccare. Ma ogni attacco riaccende il fuoco, rafforza il nemico, alimenta nuove tensioni.
Forse è il momento di affiancare alla forza una visione politica diversa. Perché la sicurezza, quella vera, nasce anche da una giustizia riconoscibile. E giustizia, in questa regione, significa accettare finalmente la creazione di uno Stato palestinese indipendente, con interlocutori legittimi e affidabili — non certo Hamas. Un processo difficile, certo, ma che potrebbe finalmente dare senso a un equilibrio fondato non solo sulla deterrenza, ma anche sulla legittimità e sul rispetto reciproco.
Finché la pace resterà un’idea astratta e non un progetto concreto, ovvero un “compromesso” ragionevole fra tutti gli Stati della regione, il Medio Oriente continuerà a giocare a scacchi con i pugni. E ogni vittoria, per quanto brillante, sarà solo il preludio a un nuovo round.
Pubblicato il 15/6/2025 su Rainews
Articoli
Tangeri, 1890. Intrigo, potere e resistenza: La strategia del pesce nano, il primo romanzo di Zouhir Louassini
Una storia avvincente ispirata a fatti reali che riporta alla luce una pagina dimenticata della storia marocchina, tra spionaggio, tensioni internazionali e dignità ferita.
 È disponibile su Amazon La strategia del pesce nano, il primo romanzo dello scrittore e giornalista marocchino Zouhir Louassini. Ambientato nella Tangeri del 1890, il libro trascina il lettore in un’indagine che va oltre il mistero iniziale – l’assassinio di un cittadino italiano – per esplorare gli intricati rapporti di forza tra il Marocco e le grandi potenze coloniali.
È disponibile su Amazon La strategia del pesce nano, il primo romanzo dello scrittore e giornalista marocchino Zouhir Louassini. Ambientato nella Tangeri del 1890, il libro trascina il lettore in un’indagine che va oltre il mistero iniziale – l’assassinio di un cittadino italiano – per esplorare gli intricati rapporti di forza tra il Marocco e le grandi potenze coloniali.
Tangeri, all’epoca, era una città di frontiera e d’intrigo, abitata da consoli stranieri, spie, mercanti e diplomatici che operavano sotto la protezione di un sistema consolare arrogante e impunito. Louassini costruisce, con eleganza narrativa e rigore storico, un giallo politico che illumina i meccanismi opachi dell’epoca, le tensioni diplomatiche e le strategie sottili adottate da chi – pur privo di potere militare – cercava di sopravvivere e difendere la propria sovranità.
Il titolo del romanzo, La strategia del pesce nano, diventa emblema di questa resistenza silenziosa: quella di chi, pur piccolo e fragile, riesce a muoversi con astuzia nel mare agitato degli imperi coloniali.
Con uno stile limpido e cinematografico, il romanzo restituisce una Tangeri affascinante e contraddittoria, sospesa tra tradizione e modernità, tra dominio straniero e orgoglio marocchino. Louassini non si limita a raccontare un fatto di cronaca: invita il lettore a riflettere sul presente, sulle relazioni di forza internazionali, e sulla sottile linea tra giustizia e impunità.