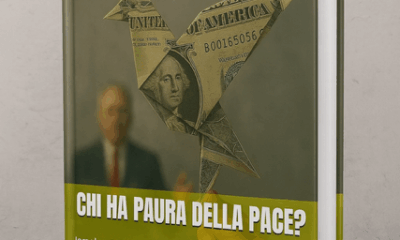Articoli
Papa Francesco in Iraq, un viaggio all’insegna della fratellanza
Niente ha potuto ostacolare Francesco nel suo viaggio verso l’Iraq: né la pandemia, né la mancanza di sicurezza, né l’instabilità politica di un paese così centrale nella storia delle religioni. Andare comunque, seppur in circostanze tanto incerte, conferma l’importanza che il vescovo di Roma attribuisce a questo “pellegrinaggio” unico ed emblematico.

di Zouhir Louassini (Rainews), 04-03-2021
La visita del Papa assume un triplice significato: un forte invito ai cristiani dell’Iraq a non abbandonare il loro paese, un’esortazione a ritornare rivolta a coloro che sono fuggiti e uno stimolo per le autorità locali affinché prendano coscienza della gravità della situazione
Rivolgendosi ai cristiani cacciati dai terroristi di Daesh, i musulmani d’Iraq postavano sui social network le immagini delle case e delle chiese che stavano riparando. Quelle foto dicevano: “Tornate!” ai Nasara (Nazareni), “tornate a casa vostra”. L’ormai prossimo viaggio del Papa a Baghdad – in programma a partire dal 5 marzo – non potrà che riempire il cuore di gioia, a gente fatta così. Mai un viaggio papale, negli ultimi anni, ha suscitato tanto interesse.
Niente ha potuto ostacolare Francesco nel suo viaggio verso l’Iraq: né la pandemia, né la mancanza di sicurezza, né l’instabilità politica di un paese così centrale nella storia delle religioni. Andare comunque, seppur in circostanze tanto incerte, conferma l’importanza che il vescovo di Roma attribuisce a questo “pellegrinaggio” unico ed emblematico.
Non c’è un momento nell’itinerario programmato dal pontefice in cui non si veda un gesto, un messaggio, un segno verso gli iracheni e, loro tramite, verso tutta l’umanità. Saranno tre giorni intensi, tanto durerà il viaggio, curati nei minimi dettagli.
Subito dopo il suo arrivo e le cerimonie protocollari ufficiali, il Papa incontrerà vescovi, sacerdoti, religiosi, seminaristi e catechisti nella Cattedrale Siro-Cattolica di “Nostra Signora della Salvezza” a Baghdad: è quello il luogo dove 44 fedeli furono uccisi in un attacco jihadista, nell’ottobre 2010.
Vittime che fanno parte del lunghissimo elenco di morti tra tutta la popolazione irachena e che sembrò, nel caso dei cristiani, il risultato di una strategia volta a mettere in atto una vera e propria pulizia religiosa, decisa da certi circoli; l’intento era chiaro: svuotare il paese della sua popolazione cristiana.
Una strategia, va detto, premiata da un significativo successo. In pochi anni il numero dei cristiani in Iraq – una delle più antiche comunità del Medio Oriente – è infatti diminuito in misura consistente: dopo l’invasione americana del 2003, a causa degli abusi subiti da parte degli islamisti fanatici e, dopo il 2014, per via delle violenze dell’autoproclamato Stato Islamico.
Anche se non esistono cifre ufficiali, organizzazioni come AED (Aide à l’Église en Détresse), stimano che la popolazione irachena cristiana, dall’invasione americana in poi, sia diminuita di oltre il 90%, passando da un milione e mezzo di fedeli nel 2003 a meno di 150.000 nel 2019.
Di fronte a questa condizione drammatica, il viaggio del Papa assume un triplice significato: un forte invito ai cristiani dell’Iraq a non abbandonare il loro paese, un’esortazione a ritornare rivolta a coloro che sono fuggiti e uno stimolo per le autorità locali affinché prendano coscienza della gravità della situazione.
Il secondo giorno il Papa si trasferirà a Najaf, la città santa dei musulmani sciiti, per una “visita di cortesia” all’ayatollah Sayyid Ali Al-Husaymi Al-Sistani. Sarà un incontro davvero “storico”, in tutti i sensi. Nonostante i suoi novant’anni, Ali Sistani è una delle personalità più influenti della vita sociale e politica del paese, anche se non ama apparire in pubblico.
Due anni dopo aver incontrato in Egitto il grande imam di Al-Azhar, il sunnita Ahmad Al-Tayeb, Papa Francesco continua a perseguire il suo sogno di fratellanza. Lo farà incontrando una delle più grandi autorità sciite del mondo. Con la differenza sostanziale che, mentre nel mondo sunnita non esiste un clero organizzato su una precisa gerarchia, nella realtà sciita la situazione è differente.
Al-Sistani è l’alta autorità nel mondo sciita iracheno. I suoi seguaci lo considerano come il proprio “papa”. Per questa ragione l’incontro, anche se di carattere privato, avrà una risonanza globale data la sua personalità e l’influenza che ha tra gli iracheni, sunniti inclusi.
Di certo l’importanza simbolica e religiosa di questo incontro non può nasconderne le sfumature geopolitiche. Di nazionalità iraniana, l’ayatollah al-Sistani è riconosciuto per la sua indipendenza e il suo desiderio di vedere l’Iraq riconquistare la propria sovranità. Le sue relazioni con l’Iran, un paese che interferisce ampiamente negli affari iracheni, sono quindi molto difficili. La scelta di incontrare al-Sistani a Najaf può dunque essere letta come un appoggio, diretto e chiaro, da parte del Papa agli sciiti iracheni.
Per molti osservatori all’interno dello sciismo è in atto una lotta per conquistarne la leadership; una rivalità che fa riferimento a due distinte scuole di pensiero: quella di Qom, in Iran, e quella di Najaf, in Iraq.
Una fa parte dell’eredità dell’ayatollah Khomeini, salito al potere in Iran dopo la rivoluzione del 1979. Questa corrente, che governa ancora Teheran, ritiene che non debba esserci separazione tra potere temporale e potere spirituale. La posizione opposta a quella della scuola di Najaf, incarnata da Ali al-Sistani. Gli iracheni, e probabilmente anche le autorità iraniane, hanno ben capito la dimensione e il senso delle scelte del Papa in questo viaggio.
Dopo la visita a Najaf, il Papa volerà a Nassiriya, per l’incontro interreligioso presso la Piana di Ur, la terra di Abramo, figura comune e interconnessione simbolica tra giudaismo, cristianesimo e islam. Qui il messaggio recato da Roma è chiaro, soprattutto per chi crede nella possibilità di parlare direttamente con Dio: saranno tutti lì, insieme con Abramo, per chiedere la pace in una terra che soffre la guerra da più di quaranta anni.
L’ultima tappa del viaggio apostolico è fissata nella regione autonoma del Kurdistan. La sua capitale, Erbil, sarà teatro del terzo “momento-clou” del viaggio di Francesco. La metropoli, che ha conosciuto una rapida espansione demografica e urbanistica, dopo il 2014 è divenuta rifugio per decine di migliaia di persone messe in fuga dai crimini di Daesh. E anche da qui, dal Kurdistan iracheno, un messaggio di pace, neppure troppo velato, correrà immancabilmente fino alle orecchie sempre attente di Ankara.
È assai probabile che, durante il suo storico viaggio in Iraq, Papa Francesco porrà l’accento più marcato sul concetto (e la prassi) della fraternità. Nella scia della sua ultima enciclica “Fratelli tutti”, ribadirà che la pace non è possibile senza il rispetto dovuto a ciascuna comunità, a ogni persona; che è possibile trovare un buon accordo tra culture e religioni differenti, nella convinzione che “le cose che abbiamo in comune sono così tante e importanti che è possibile individuare una via di convivenza serena, ordinata e pacifica, nell’accoglienza delle differenze e nella gioia di essere fratelli perché figli di un unico Dio”.
Articoli
Chi ha paura della pace?
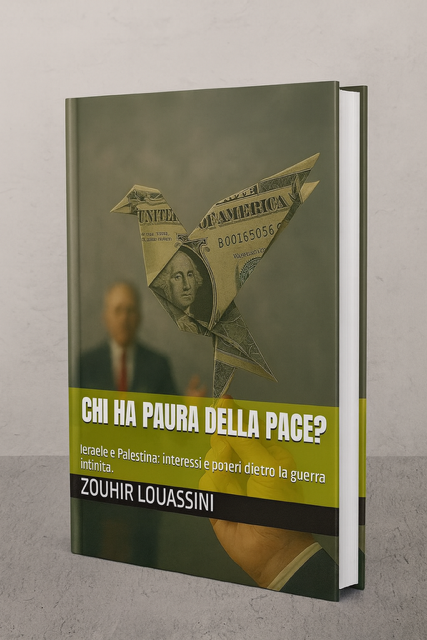
La parola pace in Medio Oriente è stata talmente usata, manipolata e svuotata che oggi sembra quasi impronunciabile. Nonostante decenni di negoziati falliti, guerre senza tregua e cicli infiniti di violenza, resta l’unica via possibile. Ma chi la ostacola? Chi ha davvero paura della pace?
È questa la domanda al centro del nuovo libro di Zouhir Louassini, giornalista e scrittore, che scava nei nodi più dolorosi del conflitto israelo-palestinese. Il volume non indulge in retorica: parte da fatti concreti, come il massacro del 7 ottobre 2023, quando Hamas ha colpito brutalmente civili innocenti, tra i quali anche israeliani impegnati nel dialogo con i palestinesi. Un atto di violenza che ha avuto un unico obiettivo: distruggere ogni possibilità di convivenza.
Ma l’autore non si ferma a denunciare la barbarie di Hamas. Con la stessa lucidità mette in luce le responsabilità del governo Netanyahu e della destra israeliana, che da anni alimentano un clima di paura, colonizzazione e vendetta. Una leadership che ha usato la retorica della sicurezza per rafforzarsi politicamente, mentre la prospettiva di una pace reale si allontanava sempre di più.
Louassini mette in parallelo queste dinamiche con l’uso distorto delle parole: leader che parlano di “pace” mentre alimentano la guerra, promesse che si trasformano in imposizioni, un linguaggio politico che ricorda le distopie di Orwell, dove i significati vengono rovesciati.
Chi ha paura della pace? è un testo giornalistico ma anche una riflessione universale: mostra come la pace faccia paura a chi vive di conflitto, a chi trae forza e consenso dall’odio. E invita i lettori a chiedersi se la guerra sia davvero inevitabile, o se esista ancora spazio per immaginare scenari pragmatici di convivenza.
Non offre illusioni, ma pone la domanda più scomoda e necessaria: la pace è davvero un’utopia, o è la nostra unica possibilità di futuro?
Articoli
Partita a scacchi su un ring di pugilato: tra Israele e Iran il nuovo round di una spirale infinita

Gaza, Hezbollah, Siria, Iran: ogni fronte è inserito in una logica coerente, volta a smantellare le reti di minaccia alla sicurezza israeliana
Nel ring infuocato del Medio Oriente, il conflitto tra Israele e Iran somiglia sempre più a un ibrido tra una partita di scacchi e un incontro di pugilato. Israele gioca con freddezza strategica: colpisce con precisione chirurgica obiettivi militari, basi e infrastrutture sensibili. Ogni mossa è calcolata, ogni attacco ha un valore operativo ma anche simbolico.
L’Iran, invece, sembra un pugile stordito. Reagisce con colpi confusi, spesso imprecisi, più guidato dall’impulso che da un piano. I droni lanciati in massa, i razzi sparati senza un bersaglio definito, le minacce ripetute ma inefficaci: tutto parla di frustrazione più che di forza.
Ma il vero squilibrio non è solo militare. È soprattutto geopolitico. Teheran si ritrova sempre più isolata. I suoi alleati storici sono in difficoltà: Hezbollah è logorato in Libano da attacchi continui e da una crisi economica devastante; gli Houthi in Yemen sono sotto tiro diretto degli Stati Uniti; Hamas, dopo l’attacco del 7 ottobre 2023, è intrappolato nella guerra brutale di Gaza. La “mezzaluna sciita”, un tempo simbolo dell’influenza regionale iraniana, si è incrinata sotto il peso della risposta israeliana e dell’isolamento diplomatico.
Anche sul piano internazionale, l’Iran non trova più appoggi solidi. La Russia, pur legata da interessi militari e strategici, è assorbita dalla guerra in Ucraina e non ha alcuna intenzione di aprire un nuovo fronte. La Cina mantiene una distanza prudente: intrattiene rapporti economici con Teheran, ma non intende compromettere la sua immagine globale per una potenza sempre più ingombrante. Mosca e Pechino giocano su più tavoli, ma oggi scelgono la cautela. Nessuno è disposto a esporsi per un Iran sempre più isolato.
Israele, al contrario, agisce con la consapevolezza di avere il vento a favore. Gli Stati Uniti garantiscono copertura diplomatica, supporto tecnologico e una forte capacità di deterrenza. Le potenze occidentali, con sfumature diverse, condividono la percezione dell’Iran come minaccia alla stabilità regionale. Anche molti paesi arabi, pur evitando dichiarazioni ufficiali, vedono con favore il contenimento dell’espansionismo iraniano. Non si può parlare di legittimità internazionale – l’ONU non ha mai approvato formalmente le azioni israeliane – ma è chiaro che Tel Aviv opera dentro un contesto di ampio consenso politico, seppur non dichiarato.
Soprattutto, Israele agisce secondo una visione. La risposta all’attacco del 7 ottobre non è stata solo militare: è parte di una strategia a lungo termine per ridisegnare gli equilibri regionali. Gaza, Hezbollah, Siria, Iran: ogni fronte è inserito in una logica coerente, volta a smantellare le reti di minaccia alla sicurezza israeliana. È una dottrina fondata su azione preventiva, superiorità tecnologica e iniziativa diplomatica.
Ma tutto questo solleva una domanda cruciale: quanto può durare questa spirale? Fino a quando la sicurezza israeliana potrà basarsi su guerre preventive, attacchi anticipati, operazioni giustificate da minacce reali o anche solo percepite? Perché anche la semplice sensazione di una minaccia, per Israele, si traduce quasi sempre in un’azione militare. È una strategia che ha prodotto risultati tattici, ma ha anche cronicizzato il conflitto. Ogni guerra genera la successiva.
Dal 1948, anno della nascita dello Stato di Israele, il Medio Oriente non ha mai conosciuto una pace duratura. Solo tregue provvisorie, pause tra una crisi e l’altra. Il paradosso è tutto qui: per difendersi, Israele è costretto ad attaccare. Ma ogni attacco riaccende il fuoco, rafforza il nemico, alimenta nuove tensioni.
Forse è il momento di affiancare alla forza una visione politica diversa. Perché la sicurezza, quella vera, nasce anche da una giustizia riconoscibile. E giustizia, in questa regione, significa accettare finalmente la creazione di uno Stato palestinese indipendente, con interlocutori legittimi e affidabili — non certo Hamas. Un processo difficile, certo, ma che potrebbe finalmente dare senso a un equilibrio fondato non solo sulla deterrenza, ma anche sulla legittimità e sul rispetto reciproco.
Finché la pace resterà un’idea astratta e non un progetto concreto, ovvero un “compromesso” ragionevole fra tutti gli Stati della regione, il Medio Oriente continuerà a giocare a scacchi con i pugni. E ogni vittoria, per quanto brillante, sarà solo il preludio a un nuovo round.
Pubblicato il 15/6/2025 su Rainews
Articoli
Tangeri, 1890. Intrigo, potere e resistenza: La strategia del pesce nano, il primo romanzo di Zouhir Louassini
Una storia avvincente ispirata a fatti reali che riporta alla luce una pagina dimenticata della storia marocchina, tra spionaggio, tensioni internazionali e dignità ferita.
 È disponibile su Amazon La strategia del pesce nano, il primo romanzo dello scrittore e giornalista marocchino Zouhir Louassini. Ambientato nella Tangeri del 1890, il libro trascina il lettore in un’indagine che va oltre il mistero iniziale – l’assassinio di un cittadino italiano – per esplorare gli intricati rapporti di forza tra il Marocco e le grandi potenze coloniali.
È disponibile su Amazon La strategia del pesce nano, il primo romanzo dello scrittore e giornalista marocchino Zouhir Louassini. Ambientato nella Tangeri del 1890, il libro trascina il lettore in un’indagine che va oltre il mistero iniziale – l’assassinio di un cittadino italiano – per esplorare gli intricati rapporti di forza tra il Marocco e le grandi potenze coloniali.
Tangeri, all’epoca, era una città di frontiera e d’intrigo, abitata da consoli stranieri, spie, mercanti e diplomatici che operavano sotto la protezione di un sistema consolare arrogante e impunito. Louassini costruisce, con eleganza narrativa e rigore storico, un giallo politico che illumina i meccanismi opachi dell’epoca, le tensioni diplomatiche e le strategie sottili adottate da chi – pur privo di potere militare – cercava di sopravvivere e difendere la propria sovranità.
Il titolo del romanzo, La strategia del pesce nano, diventa emblema di questa resistenza silenziosa: quella di chi, pur piccolo e fragile, riesce a muoversi con astuzia nel mare agitato degli imperi coloniali.
Con uno stile limpido e cinematografico, il romanzo restituisce una Tangeri affascinante e contraddittoria, sospesa tra tradizione e modernità, tra dominio straniero e orgoglio marocchino. Louassini non si limita a raccontare un fatto di cronaca: invita il lettore a riflettere sul presente, sulle relazioni di forza internazionali, e sulla sottile linea tra giustizia e impunità.