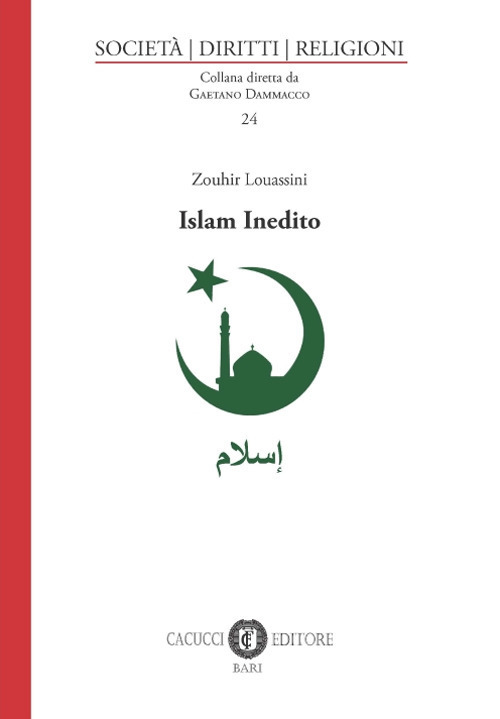Di Zouhir Louassini (Rainews)
Il giornalista libanese Jihad al-Khazen, alla vigilia degli attentati dell’11 settembre 2001, affermava: “L’Occidente non può vincere la sua battaglia contro il terrorismo se ancora non sa distinguere tra un imam e un prete.” Nel suo articolo pubblicato su Al-Hayat, al-Khazen evidenziava come l’approccio superficiale verso il mondo dell’Islam, sia da parte della stampa che dei politici occidentali, generi confusione, impedendo di affrontare i veri problemi che hanno portato al caos in vasti settori del mondo arabo e islamico.
L’attacco iraniano contro Israele, avvenuto tra sabato e domenica scorsa, ha scatenato un’altra ondata di analisi volta a interpretare la strategia di Teheran. Queste analisi vedono la realtà sciita come antagonista del mondo sunnita, spesso percepito come un alleato naturale di Israele. Gli Accordi di Abramo sono interpretati, in questo contesto, come prova di un’intesa segreta che ha evitato danni maggiori a Tel Aviv.
Considerare la rivoluzione iraniana una mera espressione dello sciismo è limitativo. È essenziale ampliare l’orizzonte per comprendere questa rivoluzione nel suo vero contesto, quello dell’islam politico. Questa prospettiva ci permette di capire il sostegno deciso e continuo che la Repubblica Islamica ha offerto per anni a Hamas, di orientamento sunnita, e ad altri movimenti emergenti dalla Fratellanza Musulmana, fondata in Egitto nel 1928. La forza di questi movimenti si è manifestata durante la primavera araba, con l’ascesa al potere di Mohammad Morsi in Egitto e di al-Nahda in Tunisia. Solo comprendendo il significato dell’islam politico possiamo interpretare l’alleanza tra il Qatar sunnita, principale finanziatore dei movimenti islamisti, la Turchia sunnita con il modello di successo rappresentato da Erdogan, e l’Iran sciita, percepito nell’immaginario arabo e islamico come un baluardo contro l'”imperialismo americano”.
Le affinità intellettuali tra l’Iran (sciita) e la fratellanza (sunnita) sono evidenti: l’ayatollah Ali Khamenei ha tradotto in persiano le opere di Sayid Qutb, un intellettuale della Fratellanza Musulmana giustiziato nelle prigioni egiziane nel 1966.
Nel 1953, il sunnita Qutb incontrava a Gerusalemme il sciita Navvâb Safavi, predicatore e fondatore dei Fedâ’iyân-e Islam, responsabili dell’uccisione di liberali e tecnocrati iraniani tra gli anni 1940 e 1960. Come sottolineava il tunisino Rached Ghannouchi, questo movimento è visto come l’erede dei Fratelli Musulmani in Iran.
Numerosi sono gli esempi che dimostrano le affinità politiche evidenti tra la rivoluzione iraniana e i Fratelli Musulmani. Fin dalla sua fondazione, la Repubblica Islamica è stata un modello per importanti leader dei Fratelli Musulmani, dal libanese Fathi Yakan al tunisino Rached Ghannouchi, fondatore del Movimento della Tendenza Islamica (MTI) – il futuro movimento Ennahda – e molti altri che vedono nella rivoluzione iraniana un esempio da seguire per riportare le loro società a un Islam considerato più puro.
Nel giugno del 2012, Mohamed Morsi, esponente del partito Libertà e Giustizia e legato ai Fratelli Musulmani egiziani, è stato eletto presidente della Repubblica. L’Iran, manifestando entusiasmo, ha applaudito la sua elezione. Solo due mesi dopo, Morsi ha visitato l’Iran in occasione del Vertice dei paesi non allineati. Questa visita ha rappresentato un evento storico: dal 1979, anno in cui l’Egitto firmò un trattato di pace con Israele, l’Iran aveva interrotto le relazioni diplomatiche con il Cairo. Tuttavia, dopo 33 anni di relazioni interrotte, un presidente egiziano è stato nuovamente accolto a Teheran, e non un presidente qualsiasi, ma un membro dei Fratelli Musulmani.
Questo entusiasmo spiega la condanna iraniana del rovesciamento di Morsi da parte dell’esercito egiziano, avvenuto nel luglio 2013, durante il quale l’Iran ha comunicato ufficialmente agli egiziani di non considerare i Fratelli Musulmani come un’organizzazione terroristica.
Nel febbraio del 2016, Oussama Hamdan, incaricato delle relazioni esterne per il movimento palestinese, ha visitato Teheran. Dopo una serie di incontri con i funzionari iraniani, il comunicato di Hamas è stato inequivocabile: si prospettava l’apertura di una “nuova pagina” nelle relazioni con Teheran. La questione palestinese è profondamente legata all’ideologia iraniana: nonostante le divergenze sulla crisi siriana, il sostegno dell’Iran a Hamas è rimasto costante nel tempo.
Solo considerando l’evoluzione dell’islam politico si possono comprendere appieno le mosse iraniane: l’attacco a Israele è stato più una risposta simbolica che effettiva. Questo si è verificato similmente quattro anni fa, quando gli Stati Uniti hanno ucciso il comandante della Forza Quds iraniana, Qasem Soleimani. L’Iran aveva necessità di una reazione simbolica per mantenere la propria immagine e ha chiesto di poterlo fare. Gli Stati Uniti hanno consentito all’Iran di attaccare la propria base aerea di Ayn Al-Asad, assicurando che nessuno venisse ferito. Quindici missili sono stati lanciati contro la base, causando danni minori e senza perdite di vite umane. Qualcuno ha commentato ironicamente l’attacco proponendo l’Iran per il Premio Nobel per la Pace per essere riuscito a lanciare 15 missili senza uccidere nessuno.
È evidente che l’islam politico trae nutrimento da queste risposte simboliche per espandere il proprio seguito. Basta osservare i social media nel mondo arabo per notare l’eco positiva che rafforza l’immagine degli iraniani come ultimo baluardo contro “l’aggressione israeliana ai fratelli palestinesi di Gaza” e come l’unico paese islamico in lotta contro “il grande Satana”, come vengono chiamati gli Stati Uniti a Teheran.
I sondaggi dimostrano che l’ideologia della fratellanza sta guadagnando terreno ovunque. Secondo uno studio del Pew Research Center, una maggioranza schiacciante di musulmani intervistati in Indonesia (91%), Libano (58%), Pakistan (69%), Nigeria (82%), Egitto (85%) e Giordania (76%) desidera un maggiore peso dell’Islam nelle questioni politiche dei loro rispettivi paesi; la stessa tendenza si osserva in Turchia (38%). E’ una ricerca pubblicata nel 2010. Oggi sicuramente i numeri saranno assolutamente più importanti a favore del discorso islamista. Questo è il vero pericolo che si sta avvicinando. I paesi arabi che hanno scommesso sulla pace con Israele sono coscienti dell’uso iraniano e dell’islam politico della causa palestinese. Questi paesi mantengono, contro le proprie opinioni pubbliche, rapporti con Israele con la speranza di risolvere la questione in un modo soddisfacente che passa obbligatoriamente per la nascita di uno Stato Palestinese. Netanyahu e suo governo devono capire questa esigenza. L’Iran – e da anni – mira a destabilizzare i paesi arabi con l’aiuto della sua quinta colonna formata da un islam politico che per arrivare ai suoi obiettivi non si ferma davanti a niente. La sconfitta politica o militare non significa in nessun modo la fine di una ideologia, quella dell’islam politico, dove c’è poco islam e molta politica.
Chi desidera analizzare la situazione attuale in Medio Oriente dovrebbe prendere in mano una mappa e osservare attentamente gli sviluppi recenti nella regione. In Iraq, lo Stato è praticamente assente, sostituito dalla milizia sciita al-Hashd al-Shaabi. In Siria, lo Stato è ridotto all’ombra di se stesso, con Bashar al-Assad, sempre più grato per il supporto iraniano e disposto ad accettare una crescente influenza di Teheran. In Libano, lo Stato è evanescente, dominato dal partito sciita Hezbollah, che segue le direttive di Teheran. Nello Yemen, la situazione è simile: non esiste più un governo centrale, ma solo le milizie sciite degli Houthi, anch’esse sotto l’influenza di Teheran. Se l’Occidente e Israele non hanno ancora compreso la portata di questi cambiamenti, allora la frase di Jihad al-Khazen, scritta 23 anni fa, rimane sorprendentemente attuale.